RUMOR(S)CENA – Rotonde catturate dall’alto come sistemi vascolari di un organismo. Il cielo, al risveglio da un incubo, appare ancora incerto, come l’avvenire, e chiunque sieda al posto di guida non ha scelta: deve finire la corsa. Ma la corsa non finisce. Un altro mese e Un giorno sbagliato (in inglese Unhinged, ossia “crollato” in senso psicotico) cadrà nel vuoto, come accade ormai da anni anche a pellicole di maggior spessore. Pazienza: l’aguzzo giocattolo “a sorpresa”, scritto da Carl Ellsworth (Red Eye) e diretto da Derrick Borte, americano di origine tedesca qui al secondo noir dopo American Dreamer, tiene sulla corda per novanta minuti, spedito, senza fronzoli e, fatto non scontato, recitato con convinzione. Non è un gran film, tutt’altro, eppure, ad una seconda, più attenta visione, si capisce che il legame con il filone detto “uomo-della-strada-che-perde-le-staffe” sia più labile di quanto non appaia e che, fra le pieghe della messa in scena, si annidino i segni del nuovo corso americano, se non il nuovo paradigma della società occidentale in sé, meglio che in opere (filmiche o saggistiche), per così dire, blasonate.
Prima di riassumere la trama, sarà meglio intenderci, però, su cosa distingua tale filone, così ben radicato nella cultura popolare a stelle e strisce, e ne faciliti l’identificazione del pubblico. Quasi sempre il protagonista, variante “urbana”, mentalmente instabile del “fuorilegge” del western classico, pur non tacendo dei gravi errori commessi, sente che perfino dal fondo dell’abisso si può ancora scegliere perché una scelta diversa non è solo auspicabile ma, quando il mondo volta le spalle, addirittura doverosa. E se anche la pazza “rivolta” del nostro venisse sedata, chi vi avesse assistito (o posto fine di sua mano) avrà ugualmente compreso, benché in ritardo: niente accade per caso e chi “regge i fili” dovrà un giorno rispondere a molte domande.

Simili principii e fosche morali si trovano, ad esempio, in Falling down dove un occhialuto Michael Douglas – perito balistico di un grosso appaltatore della Difesa, licenziato dopo il crollo dell’URSS – attraversa come una furia la “giungla d’asfalto” losangelina; altrimenti in Changing lanes di Roger Michell, dramma di un precario con famiglia a carico e dell’assurda “guerricciola” da lui mossa contro un avvocato di Wall Street. Inalterata, fra innumerevoli varianti (si veda pure il tosto He was a quiet man di Frank Cappello), resta almeno la chiarezza con la quale viene giudicato l’assetto sociale: guasto, impietoso, di esso gli “antieroi” del caso sono lo specchio, il raffinato prodotto, non l’anomalia e proprio per questo da cancellare con un colpo di spugna affinché lo stato delle cose non si riveli per ciò che realmente è o, come dice John Malkovich in Nel centro del mirino, “perché non sia mai che i mostri circolino, liberi, nel Paese dei Campanelli”.

Rimasto senza lavoro, divorziato nonché omicida seriale con metodi assai truci, Tom Cooper (Russell Crowe, massiccio e pauroso) aggiunge, quindi, un tassello al già ben assortito mosaico filmico di “aberrazioni” metropolitane. Rachel (Caren Pistorius) ha i nervi più saldi ma le manca poco per diventare come lui: non ha, infatti, previsto di trovarsi alle soglie dei quarant’anni ancora sballottata fra un contratto e l’altro, madre di un adolescente affetto da dislessia acuta (Gabriel Bateman), la cui scuola speciale costa una fortuna, sorella di un lavativo (Austin P. McKenzie) e ormai ex moglie di un uomo inaffidabile. Come se non bastasse, il quotidiano spettacolo della smorfiosa vicina di casa (Anne Leighton) con fuoriserie e mani sempre occupate da buste traboccanti di acquisti cari ed inutili, le solletica istinti delittuosi. Una mattina caotica come tante, un colpo di clacson di troppo e i destini di Tom e Rachel si incroceranno: lasciamo allo spettatore il gusto di scoprire, a mano a mano, gli sviluppi.

Le premesse, come accennato, per legare Un giorno sbagliato al filone di cui sopra ci sarebbero tutte. Stavolta, però, il diavolo è più che mai nascosto nel dettaglio. Lo scrivente non crede, come il polemista Stefano Anelli vent’anni fa, che la produzione hollywoodiana sia strettamente soggetta all’USIA, l’agenzia federale responsabile di supervisionare le telecomunicazioni americane (radio e TV) dirette oltreoceano, ciò nonostante è indubbio che le tecniche di propaganda, durante il mandato di Donald Trump, si siano affinate, persino nel linguaggio cinematografico. Innanzi tutto, a differenza degli esempi precedenti, la descrizione dell’assetto sociale veste nella pellicola di Borte un ruolo secondario: solo brevi filmati in bassa definizione nel prologo, riportanti furibonde risse in autostrada, sorpassi e sommosse di varia matrice; chi siano tuttavia gli “attori” di un simile scenario (eccetto la fugace macchietta di una donna in carriera con un mano sul volante e l’altra a pettinarsi le ciglia) o perché siano così incontenibili non viene spiegato bensì “filtrato” dagli esasperanti luoghi comuni degli speakers televisivi. Il resto oscilla tra forzature o approssimazioni (si guardino le reazioni di clienti e personale nella sequenza al fast food): la comunità è quindi presentata essenzialmente come folla, nel senso più deteriore; fluida, indefinibile, di fatto irrilevante. E il meglio deve ancora arrivare.
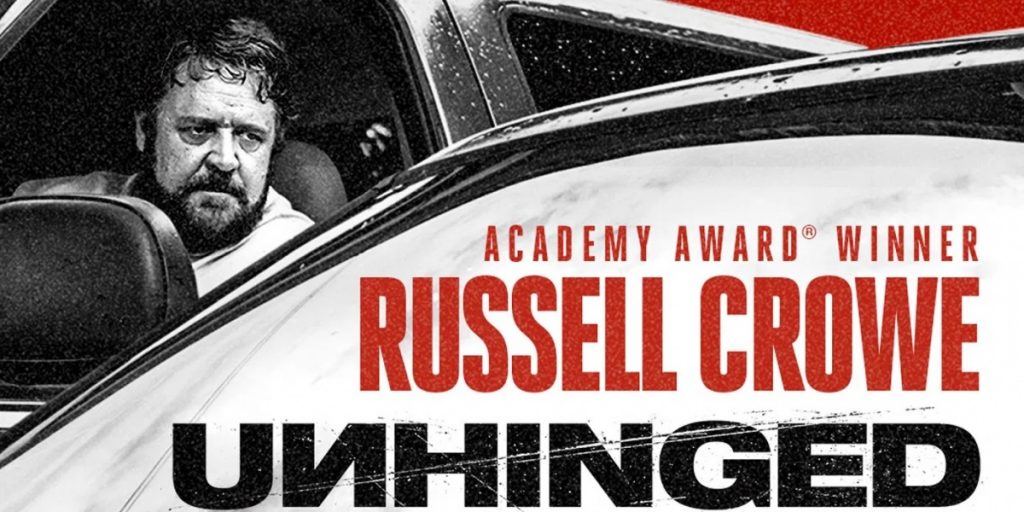
Nella parte centrale del film, Rachel si precipita alla scuola di Kyle, così si chiama il figlio, prima che vi piombi il folle Tom Cooper e accada l’irreparabile. La segretaria didattica (Devyn Tyler) si oppone all’uscita anticipata del ragazzo. Scoppia un litigio fra le due donne, inquadrate in campo medio, e intanto, sullo sfondo, la cinepresa lascia fuori fuoco un televisore acceso le cui parole sono, comunque, discretamente udibili (potenza del subliminale?): una psicologa (Donna Duplantier) sta commentando la cronaca nera degli ultimi mesi, compreso il recentissimo, tragicomico “duello” intrapreso da Tom contro Rachel; commento che così può essere ridotto: “I crescenti episodi di violenza sono spesso innescati dall’incapacità di molti soggetti di adattarsi ai ritmi della società moderna. Il processo di cambiamento è continuo, fonda nuovi bisogni, nuove pretese reciproche e, fatalmente, nuove dannose contraddizioni ma pensare di fermarlo è pura illusione”. Tombola!

Agonismo incontrollato, vergogna, invidia, incoscienza, brutali derive oggi non sono più, dunque, da considerarsi conseguenze di modelli economici e sociali rivelatisi deleteri bensì effetti collaterali dell’irrazionale, egoistica resistenza delle persone ad essi. Superata tale resistenza, per caro che sia il prezzo, un mondo migliore potrà allora cominciare. Suona cupo? Farneticante? Appena appena. Nell’ultimo decennio, girovagando tra gli scaffali delle librerie dedicati alla saggistica generale, tra videoconferenze registrate in Rete o seminari interni a manifestazioni culturali, si prova la netta sensazione di essere assillati, quando non “giudicati”, da un coro compatto, quasi euforico, composto da giovani economisti, divulgatori di filosofia, attivisti politici, esperti di comunicazione o “semplici” social influencers, il quale, riferendosi a vari settori o, più in generale, alla condotta di vita, recita: “L’innovazione genera creatività e distruzione al tempo stesso. L’animale più forte, insegna la biologia, non è quello che resiste ma quello che si adatta. Se dunque, in condizione di parità, una persona dotata di strumenti e capacità non è in grado di adattarsi o non vuole farlo per narcisismo, pigrizia o arretratezza, di chi la colpa?”
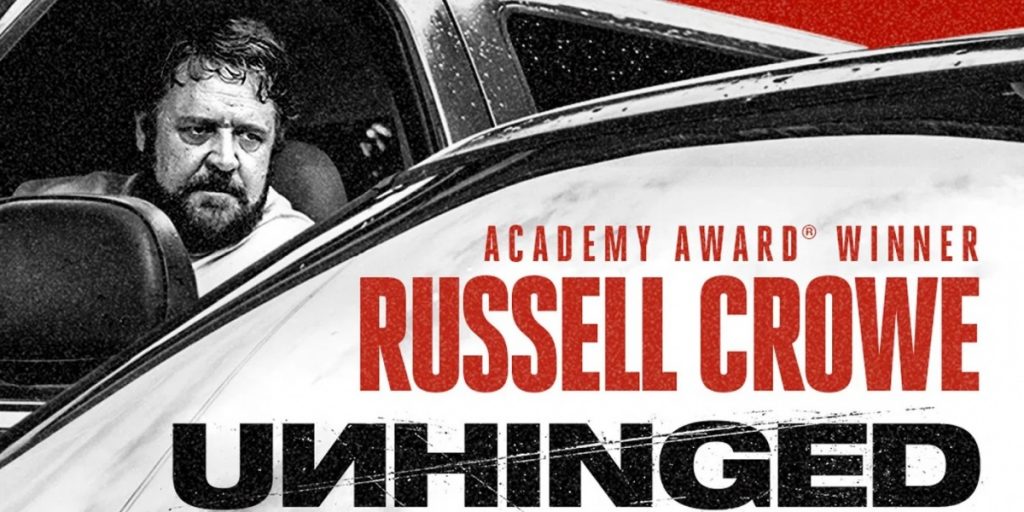
La possibilità di una scelta diversa offerta, pur con ottimismo squisitamente americano, ai protagonisti dei films succitati sembra ora avere la peggio su una contagiosa, nuova forma di positivismo seguita da un afflato “correttivo” di rado così molesto: Tom Cooper non è nato assassino, lo è diventato, resta però il fatto che nessun altro avrebbe potuto evitargli maggiori pene al di fuori di sé stesso (sicuro, ma famigliari, medici e conoscenti dov’erano quando la sua pericolosa nevrosi si sarebbe potuta intuire e curare sul nascere?); Rachel, grazie al cruento “interrogatorio” di questo Angelo Sterminatore “a quattro ruote motrici”, ha invece espiato le sue colpe (quali mai possono essere state?), imparando a non trattare più come mota il prossimo, fosse anche un occasionale “compagno di ingorgo”.
Dulcis in fundo, in quell’ultimo colpo di clacson, evitato per un soffio, pur con tutte le comprensibili ragioni, vi sarà forse più prudenza o paura? Perché è così, a rischio di eccessiva durezza, che il “tumore” della complicità con un sistema sbagliato genera metastasi, partendo dal molto piccolo: in una società sana, la rabbia verso il torto, d’ogni grado, dovrebbe essere non solo un diritto ma il minimo che renda un essere umano degno di tale nome. Mentre ai più svantaggiati o vulnerabili, mormora (senza volerlo?) il copione, in un mondo dove nulla può essere previsto con certezza, neppure la più elementare reazione emotiva, pare concessa unicamente la paura, quale freno ad eventuali disastri. Solo la Fine (che sollievo!) non ha motivo di essere temuta, neanche le stagioni la temono come dice la canzone (Don’t fear) the Reaperdei Blue Öyster Cult, riarrangiata per l’occasione dal giovane duo Keep Shelly in Athens. Efficaci, poi, ai fini della vicenda, le scenografie di Freddy Waff (Bone Tomahawk) e la fotografia fredda e “sporca” di Brendan Galvin (Escape plan).







